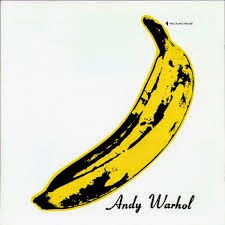la scuola, e non solo, hanno il dovere di insegnare le regole di convivenza, anche quelle sul web.
i ragazzi ne sono i maggiori (ne siamo proprio sicuri?) artefici e anche le vittime designate di una fatica a stare in relazioni costruttive che sul web trovano sfogo.
interessante il post di
Che futuro! , molto.
forse, solo, dovremmo pensare che esistono anche altri luoghi oltre la scuola.
e in primis lo dobbiamo pensare noi come educatori che in quei servizi ci lavoriamo assumendoci la responsabilità e condividendo quella degli insegnanti.
giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, i ragazzi abitano i Centri d'Aggregazione Giovanile (CAG e similari) condividendo il loro "tempo libero" con Educatori Professionali.
forse, a differenza della scuola, essendo soggetti a gare d'appalto per la gestione dei servizi non possiamo passare indenni, lasciar correre l'evento o l'episodio, la quotidianità e la normalità distorta.
ma è possibile che sia solo il lato economico ad influenzare lo studio in materia, l'interrogarsi attorno al tema e lo sperimentare pratiche che permettano ai ragazzi di diventare maggiormente consapevoli di ciò che fanno in rete (come altrove, nella vita), la necessità di crescita professionale e culturale?
tutto per il soldo?
non so.
non credo. eppure sembra che sia cosi...
oppure la differenza la fanno le persone?
non so.
non credo. eppure...
eppure ne scrivevo oggi di ask.fm, di facebook, dei sistemi di messaggistica come whatapp: sono semplici strumenti utilizzati però sempre più frequentemente per permettere ai ragazzi di stare dietro lo schermo ed influire, negativamente, pesantemente sulle vite di un capro espiatorio, al massimo di un gruppo.
il più delle volte tutto finisce li, sul web, dov'era incominciato. o forse a noi sembra cosi.
ma quanto pesano le parole, gli insulti, le aggressioni verbali?
i social networks sono molto protettivi per gli aggressori per via dell'anonimato o del fatto che non ci si conosce necessariamente nel reale mentre sono invasivi per la vittima: tutto ciò che accade è pubblico.
dal gruppo su whatsapp alle discussioni su fb o alle risposte/domande su ask le parole arrivano dirette, senza veli, senza sguardi, nette e taglienti, magari giusto arrotondate e con un po' di spessore di un emoticon.
e i ragazzi, con quello slancio verso la vita e quella necessità di confrontarsi altrove per uscire dalla propria stanza, dalle proprie relazioni familiari, dai propri schemi, i ragazzi in cerca d'identità, sono i soggetti perfetti per entrare nel meccanismo.
cosa serve allora?
serve che dall'esterno ci sia qualcuno che sminuisca o allerti, che dia "la misura", che ponga le regole e che mostri -proteggendo- quando non le si rispettano.
concordo sul fatto che la scuola abbia un ruolo centrale: i ragazzi fino ai 16 anni hanno l'obbligo di formarsi, di andare a scuola e dunque, se un lavoro di prevenzione, azione e contrasto venisse fatto li, saremmo "a cavallo". ma così non è.
e i ragazzi invece così sono. e qui vivono. con questi social networks a disposizione, con queste poche regole con cui diventare grandi.
altre volte, sul web non finisce: è solo l'inizio per incontrarsi fisicamente. a volte per abbracciarsi, a volte per scontrarsi. e se gli abbracci non fanno clamore, le risse organizzate on line tra ragazzi della "bolobene" e della "bolofeccia" mostrano il lato oscuro di cui occuparsi. da adulti.
e da professionisti dell'educazione, certo, non ci si può non sentir coinvolti.
le mani si intrecciano, un piede ci si appoggia. un breve conto e si spicca un salto che da soli, proprio, non si può fare.
mai ho visto un ragazzo rifiutare un salto come questo, in mare.
perché loro -i ragazzi intendo- ci sono.
e noi?